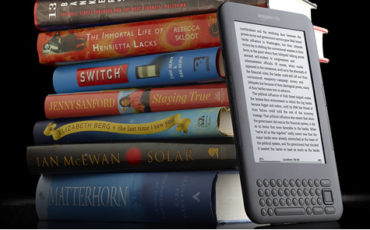La carità non è quella quantitativa e materiale, oggi tanto in auge. L’uomo che diventa oggetto di questa carità si riduce a un animale a due gambe di cui sono considerati solo i bisogni materiali, mentre le sue necessità più profonde, quali la bellezza o l’amore, sono ignorate o sono relegate nella categoria del lusso. Non vi è termine di paragone tra la carità spirituale e la carità materiale che riduce l’uomo a una bestia: gli dà cibo e vestiti, ma intanto lo priva di una protezione vera. Gli insegna a camminare, ma gli toglie la vista, la sola che potrebbe indicargli dove andare. Seyyed Hossein Nasr, Ideali e realtà dell’Islam, Rusconi 1974 di Alberto Salza.
La carità non è quella quantitativa e materiale, oggi tanto in auge. L’uomo che diventa oggetto di questa carità si riduce a un animale a due gambe di cui sono considerati solo i bisogni materiali, mentre le sue necessità più profonde, quali la bellezza o l’amore, sono ignorate o sono relegate nella categoria del lusso. Non vi è termine di paragone tra la carità spirituale e la carità materiale che riduce l’uomo a una bestia: gli dà cibo e vestiti, ma intanto lo priva di una protezione vera. Gli insegna a camminare, ma gli toglie la vista, la sola che potrebbe indicargli dove andare. Seyyed Hossein Nasr, Ideali e realtà dell’Islam, Rusconi 1974 di Alberto Salza.
Lavorando con i pastori nomadi d’Africa, mi sorprese la mancanza del termine “povero” nella loro lingua. Usano la parola araba meshkin. «Se sei povero sei morto», spiegavano. E ancora: «I poveri non siamo noi», come ribadiscono i Turkana del Kenya settentrionale (Anderson, D.M. e Broch-Due, V., 1999: The Poor are not Us. Poverty & Pastoralism, Eastern African Studies, Currey, Oxford). In realtà, anche da quelle parti, la povertà (mancanza di mezzi di sussistenza) corrisponde a un’assoluta esclusione. Non si è poveri perché non si è più umani. La miseria estrema è una condizione del tutto nuova per il nostro pianeta. L’indigenza esiste da sempre, anche se, in termini relativistici, un povero di Torino sta peggio di un povero del villaggio di Chau Doc in Vietnam. Diverse aspettative, differenti possibilità di recupero, incomparabile accoglienza sociale. Le persone della Terra, però, non avevano mai sperimentato, prima d’ora, una povertà materiale che fosse accompagnata dalla piena involuzione culturale (perdita d’identità, mercificazione, demolizione della famiglia, fine dello stato sociale, isolamento, destrutturazione educativa, terrore, guerra continua, catastrofi globali, chi più ne ha più ne metta), il tutto all’interno di quadri di riferimento sconosciuti, di scenari imprevedibili, di vuoti di pensiero: la miseria totale per corpo e mente. Su questa nuova base occorre ripensare il microcredito.
Il microcredito, per le popolazioni coinvolte dalle ONG impegnate negli aiuti umanitari, è divenuto una sorta di Culto del Cargo. Il fenomeno avvenne in Melanesia durante la seconda guerra mondiale, quando gli aerei americani cominciarono a portare grandi quantità di oggetti e cibi del tutto sconosciuti agli indigeni. Per gli isolani di Tanna, il pilota John Frum è divenuto un’icona a forma di bombardiere in croce. Ancora oggi attendono il ritorno del suo aereo che li riempirà di sviluppo e, alla fine, li porterà via dalla miseria (Worsley, P., La tromba suonerà, Einaudi, Torino 1961). Così è successo a Muhammad Yunus, il “banchiere dei poveri” che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2008, per aver ideato e diffuso il microcredito. Il guaio è che, senza conoscenze del modelli di pensiero locale, il microcredito non funziona perché i soldi non sono uguali in tutto il mondo. E il modo di farli, meno ancora. Un pastore, per esempio, minimizza il rischio e non ottimizza il profitto. Il bestiame è denaro sociale, e non verrà mai venduto.
Tra i Turkana, con cui opero da oltre trent’anni, le donne hanno il diritto di gestire il surplus di latte (quando c’è). Lo portano al mercato, lo barattano con granaglie, stoffe e quant’altro, oppure lo vendono per ricavare le rette della scuola per i figli. Perfetto, ecco dimostrato il paradigma occidentale per cui è bene affidare l’economia alle donne, che si preoccupano del futuro (i loro figli). Nell’area a occidente del lago Turkana, tramite microcredito (contenitori sterili, trasporto veloce, reinvestimenti), si è pertanto organizzata, una cooperativa per la vendita del latte.
Oggi, da quelle parti, un enorme progetto di assistenza umanitaria ha monopolizzato il mercato di carne e latte (progetto AMREF Italia, 2003: “Sviluppo rurale nelle zone aride del nord del Kenya: sostegno alle comunità pastorali Turkana nel rafforzamento delle capacità tecniche e gestionali locali”; budget attorno ai 3 milioni di euro). In tal modo, tutto è passato nelle mani degli uomini, i gestori del denaro “che conta” secondo la cultura locale. Le donne, che potevano vendere il pochissimo latte in eccedenza per procurarsi un po’ di denaro liquido per la casa e i figli, sono state tagliate completamente fuori. Senza una trasformazione strutturale della cultura locale, l’importazione di soluzioni miracolose è destinata al fallimento. A conferma, sul campo circola una notizia allarmante: la bolla finanziaria globale pare aver contagiato il microcredito. I piccoli prestiti ai più poveri fanno incassare ghiotte commissioni e interessi a due cifre.
Dato che i tassi d’insolvenza dei poveri “sottosviluppati” sono sempre stati molto più bassi rispetto a quelli dei ricchi dei paesi industrializzati (almeno finora), gli ingegneri della finanza stanno impacchettando le migliaia di piccoli crediti del contadino bengalese o della donna andina in fondi d’investimento da proporre ai clienti più danarosi. Rajalaxmi Kamath, dell’Indian Institute of Management di Bangalore (India) afferma: «Come risultato, il settore del microcredito è stato inondato da miliardi provenienti dalle banche d’affari, al punto che, per esempio in India, ci sono quartieri “bombardati a tappeto” dai crediti per poveri» (citato in Riccio, S., “Ora la bolla attacca anche il microcredito”, La Stampa, 15 agosto 2009, pag. 23). All’informazione, ormai diffusa tra gli operatori sul campo, che il tasso di solvibilità dei poveri (quanto restituiscono, a tempo debito, dei prestiti ricevuti) sia ormai garantito dagli strozzini, esattamente come avviene nelle banche dell’occidente per le carte di credito emesse a copertura di debiti di altre carte, Robert Peck Christen (esperto in microcredito per la Bill & Melinda Gates Foundation) ribadisce: «In alcune zone del mondo i tassi di interesse possono arrivare al 40%, dato che i costi per far girare le piccole somme di denaro sono astronomici. Per durare le banche dei poveri devono dare profitto» (ibidem). La rivoluzione del microcredito si è evoluta in un’operazione commerciale. Per chi analizza sistemi complessi, la faccenda era chiara dall’inizio.
Per chi opera sul campo con la prospettiva di “veder l’erba dalle radici”, è frustrante notare come l’approccio immateriale al denaro delle società a bassa industrializzazione sia trascurato da chi impone modelli umanitari nell’altrove culturale. A riguardo vi narro una storia. Di grande diffusione, soprattutto in Africa occidentale, sono le tontine, associazioni molto antiche in cui i partecipanti pagano una quota e alimentano una cassa comune di cui ciclicamente dispongono per portare a termine i loro progetti. Classicamente, la tontine, che deve il suo nome al banchiere Lorenzo Tonti (1630-1690?), è una sorta di piano di investimento in cui i partecipanti mettono quote in un fondo comune, allo scopo di: tirare a sorte un capitale per uno di loro; ricevere un premio annuale ogni volta che muore un partecipante; ottenere, con l’ultimo sopravvissuto, il possesso di tutto il fondo. Sembra una lotteria di morte, ma invece, modificata con regole meno severe, consente a persone in miseria, soprattutto donne, di risolvere collettivamente i problemi dei singoli, uno alla volta: l’acquisto di una macchina per cucire, le spese per la scuola di figli, le sementi dell’anno prossimo, ecc.
Tutti mettono un po’ di soldi per il sogno di uno di loro. L’idea di fondo è, come la mette un falegname di Dakar: «La banca non si preoccupa del modo in cui vivete e meno ancora di come spenderete il denaro che chiedete in prestito. Non c’è ostacolo all’uso del denaro della banca, poiché basta chiederlo per ottenerlo. Il denaro non è al sicuro, in banca» (Latouche, S., 1997: L’altra Africa: tra dono e mercato, Bollati Boringhieri, Torino, pag. 199). Quando un tontinier consegna il denaro, dichiara solennemente: «Questi franchi sono una miseria, ma rappresentano tutto il nostro tesoro. Noi te la diamo oggi affinché questo franco diventi dieci franchi e ciò possa esserti utile. E ti rinnoviamo tutti i nostri migliori auguri affinché tu riesca nel tuo progetto» (Henry, A., Guy-Honoré Tchente, G.-H. e Guillerme-Dieumegard P., 1991: Tontines et banques au Cameroun: les principes de la société des amis, Karthala, Parigi, pag. 28). Qualcun altro cerca di adeguarsi ai tempi moderni: investe.
Conosco Amina da oltre trent’anni. Amina ha un volto bellissimo, da vera nomade borana. L’ho sempre vista nel cortile di Chongo, il somalo guercio che mi affitta una baracca in cui vivere a Loiyangallani, in Kenya. Amina ha un piede torto, dalla nascita. Si è sposata con un uomo molto più anziano di lei, ha avuto dei figli, le è morto il marito. Non ho idea di come abbia fatto a vivere, sempre seduta nel cortile di Chongo. Quando arrivo io da quelle parti, dopo qualche giorno Amina chiede a mia moglie se, per favore, potrebbe intercedere presso di me per avere un prestito di cinquecento scellini, cinque euro. L’intermediazione è indispensabile: Amina non chiederebbe mai dei soldi direttamente a me. Usa mia moglie, che le è pari. Che fareste? Lo so che non è giusto, ma io regalo ad Amina i cinque euro, tutte le volte che me li chiede. Quel furbacchione di Yunus, non sarebbe d’accordo. Meglio un prestito con l’interesse, dato che i poveri pagano i loro debiti: nel 98,02% dei casi, contro il circa 60% degli industriali (Yunus, M., 1997: Vers un monde sans pauvreté, Lattés, Parigi; trad. it. di Dornetti, E., 1998: Il banchiere dei poveri, Feltrinelli, Milano, pag. 107-110). Yunus dice: «Rimasi sconvolto quando in Bangladesh vidi una donna ricevere in prestito meno di un dollaro, a condizione che vendesse al prestatore tutto quello che avrebbe prodotto al prezzo che lui avrebbe deciso» (Yunus, M.: “La povertà? Vada al museo”; La Stampa, 1 luglio 2008, pag. 47). In alternativa, Yunus ha prestato soldi a un tasso di interesse del 20% semestrale, ben oltre i limiti dell’usura (Yunus, 1998, op. cit. pag. 107). Yunus auspica il “business sociale”, che costruirebbe un mondo «in cui l’unico posto in cui si vedrebbe la miseria sarebbero i Musei della Povertà» (ibidem).
Che faccia tosta: per i poveri della Terra (e anche per me) i prestiti e il business non sono sociali, sono economici. E così regalo ad Amina i cinque euro. La sua idea è quella di trovare qualcosa di infinitamente poco caro da comprare con quei soldi, di modo di poterlo rivendere a pochissimo di più, dato che i clienti sono miseri come gli investitori (Salza, A., Niente. Antropologia della povertà estrema, Sperling & Kupfer, Milano 2009, pagg. 262-263). Così Amina manda qualcuno a comperare una stecca di sigarette. Estrae uno sgabello su cui mette un pacchetto aperto. Si siede a terra. E vende le sigarette, una per una, giorno dopo giorno, per un microprofitto. Con cui vive.